Culture
La pagina nera, Se a Roma c’è un crollo chi paga? E il controllo?
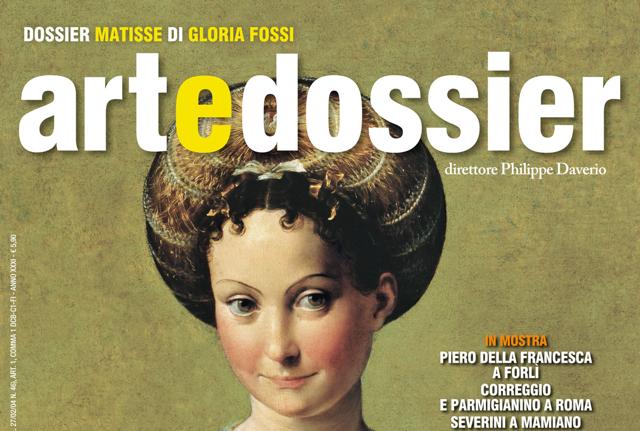
di Fabio Isman
Sul lungotevere Flaminio di Roma, all’angolo con piazza Gentile da Fabriano, non c’è un palazzo sfortunato, bensì una paradigmatica cartina di tornasole; sette piani d’uno stabile che illuminano, chiariscono, dimostrano svariate faccende. Cerchiamo di capire che cosa c’è dietro le macerie, dietro il crollo notturno (avvenuto tra il 21 e il 22 gennaio scorsi) dei tre ultimi piani di un palazzo signorile nella capitale, e cosa ancora presumibilmente accadrà. Partiamo, come direbbe Leonardo Sciascia, dal contesto. Zona Flaminio; da dove Cristina, la convertita ex regina di Svezia (abdicò ai suoi poteri nel 1654), entra nella città il 20 dicembre 1655 dopo un viaggio per l’Europa con un seguito di duecentocinquantacinque persone e duecentoquarantasette cavalli, passando sotto la porta di piazza del Popolo appositamente rifatta da Gian Lorenzo Bernini. All’epoca la zona era campagna. Qui vicino, il 7 novembre 1925, Francesco De Pinedo ammara con il suo idrovolante sul Tevere, dopo la celebre trasvolata: cinquantacinquemila chilometri fino a Sidney, sette mesi in aria. L’edificio in parte crollato non c’era ancora, pur se già previsto. Il piano regolatore del 1909, voluto dal sindaco Ernesto Nathan e opera di Edmondo Sanjust di Teulada (poi senatore del regno), che per primo regolamenta l’espansione fuori dalle mura aureliane, disegna infatti, con il vertice proprio in piazza Gentile da Fabriano, un piccolo “tridente”. È palesemente ispirato a quello del centro storico (in piazza del Popolo, con via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta); i tre rami sono viale Pinturicchio, via Guido Reni e viale del Vignola. Tra piazza Gentile da Fabriano e il lungotevere c’è l’edificio crollato.
«Il tridente nasce anche perché lì era previsto un ponte sul fiume. Ma poi si crea il Foro Mussolini, ormai Italico, e lo scavalco viene spostato più a monte», dice Giorgio Muratore, architetto e docente all’università romana della Sapienza. Ecco la prima di una serie di anomalie: sostituirà quello all’epoca non realizzato il ponte Duca d’Aosta di Vincenzo Fasolo, nel 1942. Ponte concepito nel 1939, quando è ormai conclusa la costruzione del palazzo crollato, iniziata nel 1928. All’inizio erano cinque piani: non architettura «intensiva», nella dizione del piano regolatore del 1909, bensì la classica palazzina romana. Ma intanto i piani sono diventati sette, forse recuperando anche quelli dove si trovavano anche i desueti “cassoni” per l’acqua, e facendo dello spazio «uno dei più formidabili paesaggi: San Pietro da un lato e Monte Mario con villa Madama di fronte» (Muratore).
La zona borghese è divenuta alto-borghese; anzi, un’area assai appetita. Nel paese delle sanatorie e dei condoni edilizi (tre dal primo governo Craxi all’ultimo Berlusconi), c’è poco da stupirsi. Nell’area dei palazzi della Generale Immobiliare (quella dell’Hilton appunto di Monte Mario: Capitale corrotta, nazione infetta, per citare un celebre titolo dell’“Espresso”), che «costruiva bene, anche perché lucrava sui terreni e ne possedeva in quantità» (continua Muratore), dell’antica operazione prevista dal piano regolatore di inizio secolo resta soltanto la memoria. Un quartiere di caserme è oggi quartiere di musei e attrazioni musicali (il Maxxi e l’Auditorium di Renzo Piano, con il Teatro olimpico, coinvolto nel crollo): finalmente, davanti al “tridente” di Nathan/Sanjust è sorto perfino il ponte; anche se è soltanto una passerella pedonale intitolata alla Musica, e purtroppo assai poco frequentata. Più a valle, c’è il ponte del Risorgimento: cento metri a campata unica (allora la più ampia al mondo, con il “sistema Hennebique” della società Porcheddu), tra le prime costruzioni in cemento armato in Italia, edificato dal 1909 al 1911, voluto ancora da Nathan.
Ma, nel frattempo, è arrivata la “deregulation”, principio in base al quale si afferma che ognuno debba essere “padrone in casa propria”. È sufficiente una dichiarazione d’inizio lavori; vige il principio del “silenzio assenso”; in teoria, spetterebbe ai Comuni vigilare sui lavori, ma in pratica non avviene quasi mai. Troppi uffici tecnici comunali sono andati in disarmo; e a Roma, ogni anno, i vigili urbani individuano milleottocento abusi edilizi. Così, quel palazzo, che pure aveva fatto la guerra, non ha resistito alla speculazione, ed è stato sconfitto. Proprio davanti ai “muraglioni” sul Tevere, alti diciassette metri per imbrigliare un alveo largo cento, edificati nel corso di cinquant’anni: dal 1876 (alcuni anni dopo la presa di Roma) al 1926; proprio quando si inizia a pensare all’edificio ora in parte crollato.
E adesso («pover’uomo», avrebbe aggiunto lo scrittore tedesco Hans Fallada, per citare il titolo del suo capolavoro del 1932)? I danni sono ingentissimi. Macerie da sgomberare; immobile da mettere in sicurezza; automobili andate distrutte; teatro sbarrato e programmazione sospesa. Un primo calcolo li valuta in oltre dieci milioni di euro; le opere urgenti, a carico dei condòmini tutti: non solo quelli coinvolti nel crollo dei tre piani. E per pura fortuna, in piena notte, non vi sono state vittime: un’inquilina, avvertendo gli scricchiolii, ha dato l’allarme e i vigili del fuoco, intervenuti con tempestività, hanno sgombrato l’intero stabile. Anche se colei cui tutto questo si deve non è residente a Roma, pur abitando lì; e quindi, non ha avuto diritto a una sistemazione del Comune in cui riparare.
L’Italia, si sa, vanta il maggior numero e la massima densità di avvocati al mondo: duecentocinquantamila circa; soltanto a Roma se ne contano tanti quanti in tutta la Francia. Si è instaurata una terribile spirale di perizie e controperizie, di inchieste, di magistrati e (si può esserne certi) tre gradi di giudizio. Le assicurazioni, se invocate, saranno le prime a tirarsene fuori; nessun vizio strutturale, e nessuna fatalità: soltanto colpe umane. Una colonna, o dei muri rimossi al quinto piano? E quanto pesavano i moltissimi vasi pieni di piante sulla terrazza del sesto, la cui rimozione era stata già chiesta da almeno un paio d’anni, ma invano? Nell’Italia dove, a seconda delle norme comunali, esistono ottomila modi diversi per definire una ve-randa, non sarà facile trovare una soluzione. E alla fine, chi dovrà forse pagare, difficilmente avrà le risorse per farlo. «Non vedo assolutamente nessuna conclusione», riflette amaro Muratore. Non ci sono morali da trarre: solamente una bruttissima storia da raccontare, fatta anche di mille inadempienze, pubbliche e private.



