Culture
“Le Assaggiatrici” di Rosella Postorino arriva al cinema: un’opera attesa tra memoria, finzione e introspezione femminile
La storia a lungo sconosciuta delle assaggiatrici di Hitler dal romanzo Premio Campiello della Postorino al grande schermo grazie al regista Silvio Soldini

Dopo anni di anticipazioni, finalmente approda nelle sale italiane il film Le Assaggiatrici, tratto dall’omonimo romanzo vincitore del Premio Campiello firmato da Rosella Postorino. Abbiamo assistito al debutto cinematografico dell’opera al Cinema Gabbiano di Senigallia, sempre attento ai titoli di grande valenza storico-culturale: distribuita in Italia da Vision Distribution, con la regia affidata alla sensibilità visiva e narrativa di Silvio Soldini, la pellicola è una co-produzione italo-belga-svizzera, con una buona sceneggiatura frutto del lavoro di gruppo di Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia.
C’è da avvertire subito gli appassionati del romanzo: il film vi si discosta parecchio, soprattutto nella seconda parte, dove la vicenda di Elfriede viene totalmente modificata, il ritorno del marito disperso Gregor non esiste – così come sono state tagliate del tutto le scene mondane a casa dei baroni presso cui lavora il padre di Gregor – e anche la figura del tenente Ziegler ne esce più crudele di quanto non sia nel libro. Tuttavia, come ben si sa, se ci si approccia a un’opera cinematografica con in mente il romanzo da cui è tratta, quasi sicuramente si resterà delusi; e questo è invece un bel film che vale la pena di vedere.

Nel ruolo della protagonista Rosa Sauer risulta del tutto credibile – anche a livello di fisicità ed estetica – l’interpretazione intensa e al contempo misurata dell’attrice Elisa Schlott, che presta il volto e l’anima a una donna dilaniata tra il dovere e il desiderio di sopravvivenza. Il suo personaggio è stato ispirato da Margot Wölk, l’unica assaggiatrice di Hitler sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, che ha potuto far emergere una realtà altrimenti tenuta nascosta per molto tempo. Accanto a lei, un cast corale al femminile che include Alma Hasun (Elfriede), Emma Falck (Leni), Olga von Luckwald (Heike), Thea Rasche (Augustine), Berit Vander (Ulla), Kriemhild Hamann (Sabine) ed Esther Gemsch nel ruolo di Herta, l’anziana madre di Gregor. A interpretare l’unica figura maschile di rilievo, il tenente Albert Ziegler, è invece Max Riemelt, che veste molto bene i panni della SS spietata ma pur sempre in grado di slanci romantici e di momenti di dolcezza.

Come si accennava sopra, l’ispirazione originale di Rosella Postorino prende spunto dalla reale testimonianza di Margot Wölk, unica sopravvissuta del gruppo di donne tedesche costrette a fare da assaggiatrici per Adolf Hitler. Tuttavia, l’autrice ha scelto di non ambientare il racconto nella Germania della testimone, bensì di spostarlo nel cuore della Prussia orientale, costruendo un personaggio fittizio ma profondamente autentico.
Berlino è quindi solo un’eco lontana: la città bombardata dagli americani, quella in cui la madre di Rosa è deceduta sotto il crollo della loro casa e al tempo stesso il luogo del ricordo, della nostalgia, dove Rosa colloca nella memoria tutti i momenti più importanti vissuti con il marito Gregor, partito poco dopo il matrimonio.
Il progetto cinematografico ha richiesto molto tempo in scrittura e ricerca, anche per via della complessità storica e psicologica da restituire sullo schermo. «Il libro di Rosella ha un respiro internazionale, eppure è profondamente italiano per la sua attenzione ai dettagli emotivi e psicologici. Era importante non snaturarlo» hanno spiegato gli autori della pellicola, dalla quale si è però tenuta fuori la stessa Postorino, preferendo non entrare neppure nella stesura del soggetto, affidata a Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia.
La qualità del film, a differenza di molte trasposizioni prettamente italiane, è alta, dalla fotografia alla regia, dalla sceneggiatura alla recitazione. Le riprese hanno visto un accurato lavoro scenografico per ricreare l’atmosfera ovattata e asfissiante del quartier generale del Führer, dove si consuma il dramma silenzioso delle protagoniste; al contempo viene rappresentato anche l’ambiente rurale, spartano ma genuino della campagna che circonda “la tana del lupo”. È qui che vivono i genitori di Gregor ed è quindi qui che si trasferisce Rosa prima ancora di sapere della sua scomparsa – il marito viene dato per disperso poco prima di Natale –, ignara di gettarsi così dentro un pericolo ancora più grande dei bombardamenti a Berlino. Le assaggiatrici erano retribuite e tutte donne tedesche in salute, eppure non era concesso loro di rifiutare: qualunque forma di tentennamento – fosse anche un giorno di indisposizione – aveva le sue gravi conseguenze.

Le scene forse più forti e toccanti de Le Assaggiatrici sono quelle ambientate dentro la mensa in cui le donne furono costrette a consumare i pasti “avvelenati”: nella realtà le probabilità che ciò avvenisse erano piuttosto basse, tanto che si trattò forse di un’eccessiva precauzione di Hitler, consapevole della quantità di nemici pronti a tutto pur di eliminarlo, come testimonia il famoso attentato non riuscito per poco del 20 luglio 1944. Eppure, un episodio di intossicazione si verificò davvero, a causa di una partita di miele difettosa, svelando la totale indifferenza delle SS nei confronti delle donne, lasciate sole a morire oppure a sopravvivere, senza ricevere cure mediche.
Rispetto al libro, il film rinuncia anche a molte delle riflessioni interiori della voce narrante, privilegiando il linguaggio del corpo e dei silenzi. Rosa, sullo schermo, parla poco ma comunica attraverso gli occhi, i gesti trattenuti, i respiri spezzati, i sorrisi e la voglia di vivere – espressa anche attraverso il desiderio fisico – che non la abbandona nonostante la guerra, la paura e il dolore per la scomparsa di Gregor. La scrittura della Postorino, fatta di frasi tese e soffocate, trova nella regia di Soldini una traduzione fedele nel ritmo a tratti lento e ipnotico del montaggio.
Anche il gruppo delle altre assaggiatrici è reso con una dettagliata attenzione visiva: ciascuna ha un volto ben definito, una storia accennata, un background personale spesso fatto di sofferenza che emerge nei piccoli dettagli — una fotografia di famiglia nascosta, una preghiera sussurrata, un gesto di ribellione trattenuto – oppure in alcuni segreti più gravi che non sveliamo per non fare troppo spoiler. La solidarietà femminile è la chiave di lettura sia del libro che del film, specialmente nell’amicizia sempre più stretta che si viene a creare tra Rosa ed Elfriede, ma più in generale nel sostegno, nell’affetto e nella complicità che il gruppo sviluppa al suo interno, superando le differenze iniziali e le diversità.
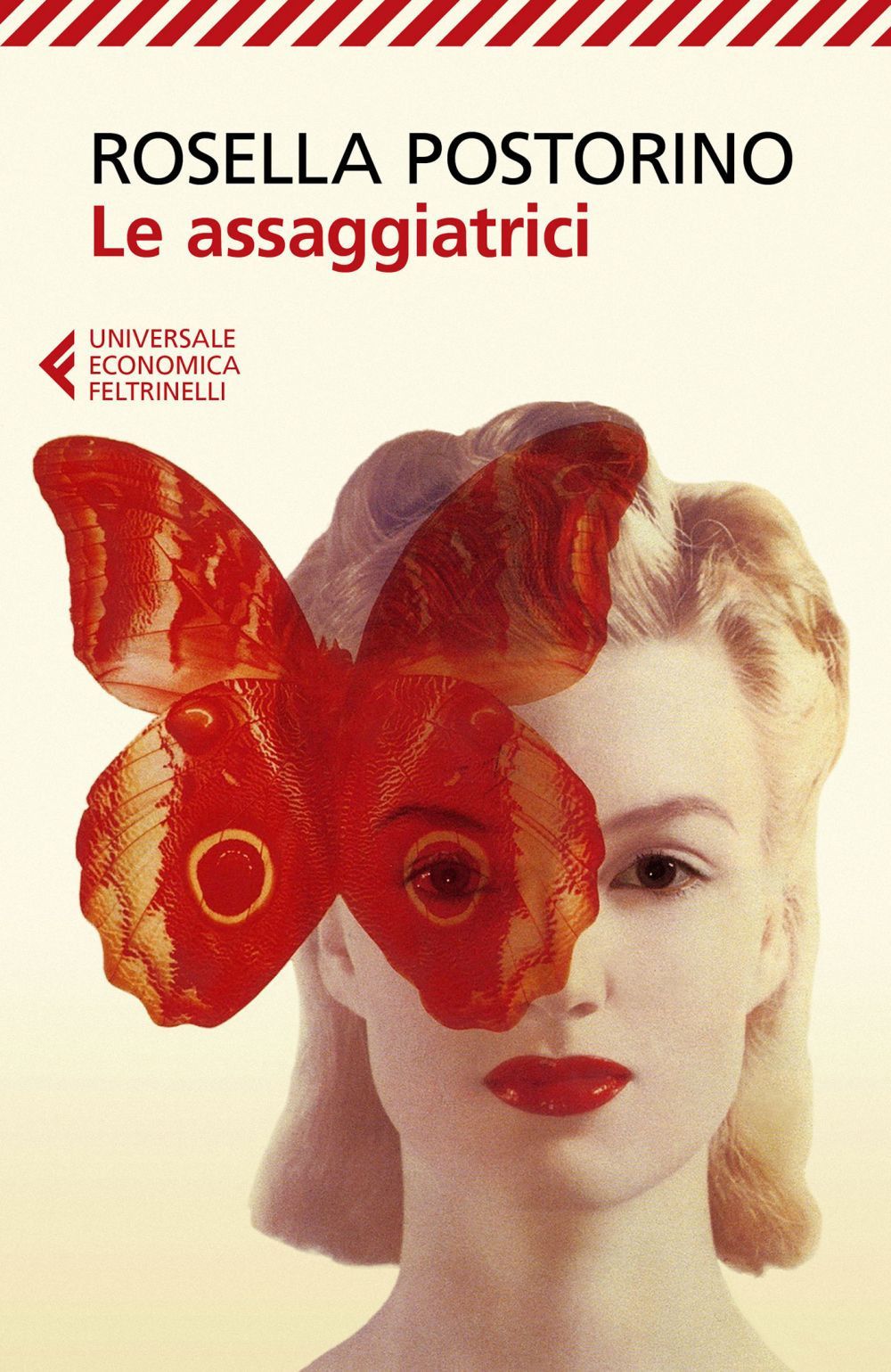
Pubblicato nel 2018 da Feltrinelli, Le Assaggiatrici è stato un successo immediato, conquistando il Premio Campiello, il Premio Rapallo e numerosi riconoscimenti internazionali, con traduzioni in oltre trenta paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania e Giappone.
Rosella Postorino, nata a Reggio Calabria ma cresciuta in Liguria, ha alle spalle una produzione letteraria solida e raffinata. Prima de Le Assaggiatrici aveva già pubblicato titoli apprezzati dalla critica come Nella stanza di sopra (Premio Rapallo e nella dozzina del Premio Strega); in seguito è invece arrivata nella cinquina del Premio Strega 2023 con Mi limitavo ad amare te, a mio parere la sua opera migliore fino ad oggi. La sua prosa si distingue per la capacità di unire introspezione psicologica e tensione narrativa, con una scrittura misurata ma densissima, frutto anche di un’approfondita ricerca storica.
Il romanzo ha suscitato un entusiasmo trasversale, con recensioni entusiastiche su testate come Il Sole 24 Ore e The New York Times, che lo ha definito «un ritratto di potenza femminile in un mondo che nega alle donne ogni scelta». Anche il pubblico ha risposto con calore, facendo del libro un longseller che ha superato le 300.000 copie vendute in Italia.
In un incontro alla Feltrinelli di Milano l’autrice ha ribadito come Le Assaggiatrici non sia una semplice storia di donne, amore e difficoltà in guerra: «È un’indagine sul compromesso morale, su cosa siamo disposti a fare per restare vivi. E forse anche su quanto ci sentiamo colpevoli per esserci salvati».
Con l’uscita del film, Le Assaggiatrici si conferma non solo un’opera di finzione storica, ma un affresco universale sulla resistenza femminile, sulla memoria e sull’ambiguità del sopravvivere. Un doppio racconto, in prosa e in immagini, che lascia un’impronta indelebile.



