Libri & Editori
E lo stato malandato si dimentica il privato
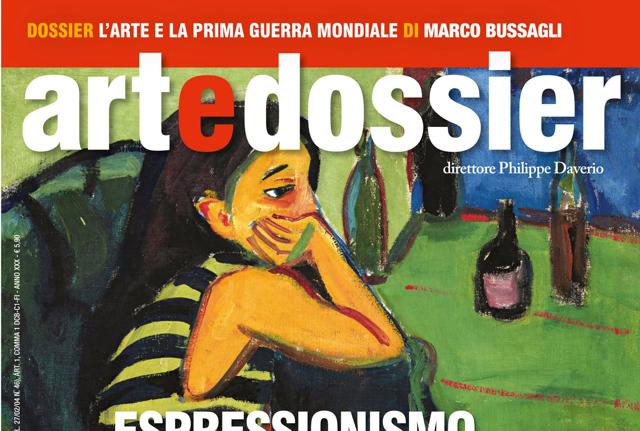
di Fabio Isman
Da decenni si discute di come integrare il privato nel salvataggio, nel restauro, nella manutenzione, nella valorizzazione e nella gestione del patrimonio artistico e storico. Lo Stato e gli enti locali da soli non ce la fanno, lo si è abbondantemente visto. Ma poi, quando un privato capita all’orizzonte, armato di tanta buona volontà e perfino disposto a qualche ingente donazione, non sempre viene trattato “comme il faut”; anzi, spesso, Stato e Comuni si dimenticano degli impegni assunti, nascondono i reperti ricevuti, non li valorizzano come invece avevano sottoscritto di fare, li mettono in un magazzino. Magari anche perché gli mancano gli uomini e le risorse per poter provvedere. Cominciamo da un paio di casi, abbastanza eclatanti; di altri parleremo in un prossimo futuro. Partiamo da due “buchi neri” romani: l’armeria già del principe Odescalchi e uno dei musei che, a Villa Borghese, appartiene al Comune di Roma. Quest’ultimo è intitolato al collezionista Carlo Bilotti, che nel momento della sua costituzione, una decina d’anni fa, ha donato al museo opere di Giorgio de Chirico, Gino Severini, Andy Warhol e Larry Rivers, e una scultura di Giacomo Manzù.
L’armeria non è gentilizia, ma il frutto della passione di un principe: Ladislao Odescalchi (1846-1922). Quanto mai eterogenea, spazia dagli esemplari più antichi – etruschi, greci e romani, perfino del V secolo – fino al Settecento. Si ignora quale fosse la sua esatta consistenza: i pezzi sono andati parzialmente dispersi per eredità. L’armeria, nel palazzo di piazza Santi Apostoli – già Colonna e Ludovisi, poi Chigi, con la facciata creata da Bernini, raddoppiato nel corpo principale da Luigi Vanvitelli e Nicola Salvi – era formata da duemilatrecento pezzi nel 1925, e costituiva una tra le collezioni d’armi più importanti d’Europa: alcuni reperti erano perfino più rari di quelli famosi conservati nella Torre di Londra. Milleduecento esemplari sono acquistati dallo Stato nel 1953; e quasi seicento vanno invece nel castello di Bracciano, una tra le più belle dimore feudali esistenti, edificata per gli Orsini nel 1470, attorno a una rocca risalente a duecento anni prima.
Nel 1957, nel romano palazzo Venezia, ottocento pezzi sono esposti nei saloni monumentali: quelli già di Paolo II Barbo, poi di Mussolini quando era il duce. All’inizio degli anni Ottanta, tuttavia, spariscono: un paio di mostre all’inizio degli anni Duemila, e basta. «Non c’ero ancora, in quegli anni», dice l’attuale direttrice del museo di palazzo Venezia, Andreina Draghi, «però, quelle armi erano state allora destinate alle sale delle esposizioni temporanee, e sono state sfrattate da una mostra su Garibaldi».
Da allora, visto che si tratta di armi, sono stati anni di lotte e di battaglie. «Con i collaboratori, ho lavorato quattro anni per riuscire a esporle di nuovo; da settembre 2015, trecento pezzi dovrebbero essere sistemati in quattro sale, che ho chiamato la Galleria delle armi. Solo nel 2012 siamo riusciti a costruirne le vetrine: prima non c’erano i finanziamenti. E ho provveduto di persona, con chi mi aiuta, a cavarle fuori dalle casse per collocarvele. All’esposizione permanente affiancheremo una mostra, che si intitolerà L’armatura è di moda, con abiti di stilisti che si sono ispirati a questi oggetti bellici». Speriamo che il diavolo non ci metta, una volta di più, la coda.
Ma intanto è caduta l’idea di affiancare a questa altre simili collezioni, di cui lo Stato dispone, e mostrarle negli spazi, vuoti e angusti, di Castel Sant’Angelo. Poteva non essere una pessima idea. E per capire ora la magnificenza che la raccolta Odescalchi possedeva all’origine restano soltanto decine di splendide immagini, riprese nel palazzo di piazza Santi Apostoli. Quello con la Conversione di Saulo di Caravaggio (chiamato anche Caravaggio Odescalchi per distinguerlo da un altro dipinto sullo stesso tema conservato nella basilica romana di Santa Maria del Popolo), e tanto altro. Alle armi e armature erano dedicati parecchi saloni affrescati: splendide panoplie; cavalieri in sella e grandi vetrine che coprivano intere pareti di numerose sale; lance, spade, armi da fuoco; intere corazze da torneo e da guerra; modelli assai rari e anche altrettanto decorativi.
Gli Odescalchi erano ricchissimi. Tra l’altro, detenevano anche quattro serie magnifiche dei celebri arazzi già di Cristina di Svezia, che ne possedeva addirittura centoquarantuno: alla sua morte, superando nell’agone parecchi sovrani europei, una buona parte se l’aggiudica, offrendo centoventitremila scudi, Livio I Odescalchi, nipote di Innocenzo XI – papa dal 1676 al 1689 – che pose invano la propria candidatura come re di Polonia.
L’ultimo principe Ladislao, nell’Ottocento, viveva a palazzo Rondinini (Roma) e nel castello di Palo: la cui Posta vecchia, una dépendance che è ormai un albergo di quelli con più stelle, è stata a lungo la residenza del miliardario Paul Getty (e, raccontavano Federico Zeri e Alvar González-Palacios, che ne erano stati ospiti, in foresteria esisteva soltanto un telefono a gettone). Anzi, si narra anche la curiosa storia di una querelle tra il principe e i birocciai, che trasportavano il vino dai Castelli. Questi, un bel giorno, incendiano le case attorno al castello; poi, scoppia la pace; e per siglarla, Ladislao regala loro un vasto appezzamento di terra, su cui nascerà una nuova città: appunto Ladispoli, quella di Ladislao. E dispone, per testamento, che non siano ricostruiti i tetti bruciati: un erede vi ottempera ancora, e qualche edificio è rimasto come era. Se non è vera, la storia è però ben inventata. Tuttavia, la grande passione del principe, la sua collezione di armature, dacché lo Stato l’ha acquistata è rimasta per più tempo chiusa nei depositi che esposta. E ora, finalmente, speriamo di poterla rivedere, almeno in una sua piccola parte: trecento esemplari sui milleduecento che erano stati comperati dallo Stato oltre sessant’anni fa.
Diversa è la vicenda del Museo Bilotti. Una collezione permanente con le opere donate nel 2005 da Carlo Bilotti, e mostre temporanee nell’ex aranciera dei Torlonia a Villa Borghese, che era già parte del complesso del cardinal Scipione, cui si deve la “regina delle collezioni private” del mondo, la quadreria, che per fortuna esiste ancora. A settembre 2014, il museo si è allagato: tutto finisce nei depositi del Macro, il museo comunale d’arte contemporanea di Roma, nella sede dell’ex Birreria Peroni. Le sale restano desolatamente vuote per oltre sei mesi. Al Comune spiegavano che mancavano i cinquecento euro per garantire l’assicurazione dei quadri durante il trasporto, nel viaggio di ritorno (dal Macro al Museo Bilotti). Sono corse perfino serie minacce di revoca della donazione. Anche dell’unico “doppio ritratto” mai eseguito da Andy Warhol: quello di Tina Bilotti e della figlia Lisa, morta a vent’anni di leucemia. Nel loro nome già esistono fondazioni d’arte anche a Cosenza e nel Castello aragonese di Rende (nella stessa provincia calabrese).
Poi, finalmente, a metà marzo 2015, le opere sono ritornate nel museo. Non però due panche di Pietro Consagra, donate cinque anni dopo, con l’espresso vincolo di essere esposte nel piazzale antistante al museo. Ciò che però non è mai accaduto: da allora sono sempre rimaste in un magazzino, non più lontano di dieci metri dal luogo di destinazione. E ora, anche lo stesso museo è in pericolo: dopo i “tagli” del bilancio comunale che hanno colpito, a Roma, la cultura: decurtata nella misura del 27 per cento. E si minaccia perfino di chiudere i musei con nemmeno ventimila visitatori all’anno: il Barracco (di scultura antica, che il nobile e deputato nel primo parlamento italiano Giovanni Barracco, appunto, ha donato al Comune nel 1902), quello dello scultore Pietro Canonica (1869-1959), anch’esso a Villa Borghese, e, appunto, il Bilotti. Gli eredi chiederanno la revoca della donazione, il cui valore viene stimato sui venti milioni di euro, più il Warhol, un cui simile, ancora romano, è stato recentemente venduto per cento?
Poveri privati: vengono invocati e appetiti; ma poi, quando ci sono e arrivano, sono spesso maltrattati, se non dimenticati.




